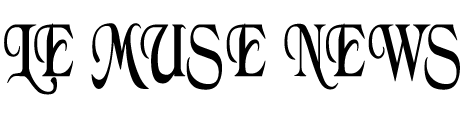CIVITAVECCHIA – Ieri pomeriggio presso la Casa di Reclusione “Giuseppe Passerini” si è svolto un incontro storico con Piero Terracina. L’evento si è svolto nell’ambito del progetto “Menti Dentro” di cui Don Sandro Mambrini è responsabile. L’incontro è stato realizzato grazie alla Direttrice Dott.ssa Patrizia Bravetti in collaborazione con l’area educativa diretta dalla Dott.ssa Marianna Marini. Presenti Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Cariciv, Palmina Falla Presidente della sez. locale della Fidapa, Manlio Luciani della Cri Comitato di Civitavecchia, Massimo Magnano Responsabile locale della Comunità di Sant’Egidio, la Consigliera comunale Paola Rita Stella, Giovannino Marseglia in rappresentanza della sez. AIA (arbitri) di Civitavecchia, Enrico Ciancarini presidente della S.S.C., docenti dell’Istituto comprensivo di Monte Romano e Vetralla, Dott.ssa Manila Di Gennaro e la polizia penitenziaria senza la quale non sarebbe stato possibile fare incontri aperti anche alla cittadinanza.
Dott.ssa Patrizia Bravetti (Direttrice della Casa di Reclusione): “Sono onorata di avere con noi Piero Terracina, sopravvissuto ad Auschwitz Birkenau che condividerà la sua testimonianza. Ringrazio Don Sandro che ha consentito la realizzazione di questo incontro e saluto tutti i partecipanti”. Don Sandro Mambrini: “L’incontro di oggi è di grande importanza storica”.

Piero Terracina: “Questo incontro non sarà facile. Evito di entrare nei particolari del’orrore che anche io ho vissuto. Da ragazzo sono stato all’inferno creato da uomini per altri uomini, era il campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. Quello è un luogo di morte. Ero colpevole di professare una religione diversa e per questo oltre sei milioni di ebrei furono sterminati. L’80% delle persone che entravano nel lager venivano uccise nelle camere a gas, il restante 20% venivano sfruttati fino alla morte. Una fila continua di padri, madri, fratelli e sorelle uscivano attraverso il fumo e le scintille. Arrivai in quel luogo quando compii 15 anni e fui deportato con la famiglia. Oltre i miei genitori eravamo quattro figli, io ero il più piccolo, ed i nonni paterni.
Nel 1938 furono emanate le leggi contro gli ebrei: ci venne precluso lo studio, non potevamo frequentare più le scuole italiane. Ma noi eravamo italiani a tutti gli effetti; fummo costretti a frequentare quelle ebraiche. A quel tempo facevo la quarta elementare e mi dovevo iscrivere alla quinta. I miei amici sparirono, rimasi solo. Frequentai la scuola ebraica e strinsi nuove amicizie. I professori di religione ebraica furono licenziati dalle scuole e dalle università, anche gli accademici furono mandati via dalle accademie. Il partito fascista promulgò leggi stringenti: tutti i professionisti furono cancellati dagli ordini professionali.
Mio padre perse il lavoro e i miei fratelli iniziarono a lavorare nelle aziende ebraiche. Vennero proibite attività culturali e sportive. Non potevamo giocare a calcio come facevano gli altri giovani, però nella zona di San Lorenzo c’era un campo di calcio dove ci fu consentito di stare. Non potevamo andare a mare; le coste della penisola e delle isole furono dichiarate di importanza strategica. Non potevamo vendere lana da materassi, pubblicare libri, articoli e ricerche scientifiche.
Il 28 settembre 1943 il comandante della Gestapo a Roma Kappler chiamò il Capo della Comunità Ebraica locale e chiese di portare entro 36 ore ben 50 chili d’oro, altrimenti 200 padri di famiglia sarebbero stati deportati. Fu una corsa contro il tempo, la solidarietà fu tanta anche da parte di molte persone che non erano di religione ebraica. Venne portata la quantità d’oro richiesta. Circa 20 giorni dopo le S.S. con la polizia circondarono il ghetto e portarono via tutti. Furono arrestate 1252 persone, di cui 230 rilasciate in quanto riuscirono a provare che non erano di religione ebraica. Il giorno dopo 1023 italiani furono portati alla stazione Tiburtina. Anni dopo tornarono a Roma 15 uomini ed una donna, lei era Settimia Spizzichino donna coraggiosa che sentì il dovere di raccontare alle masse gli orrori che aveva visto e vissuto. Quel 16 ottobre con la mia famiglia riuscimmo a scappare: mio padre mi disse di andargli a comprare le sigarette, poi lo vidi arrivare di corsa e mi disse di fuggire via con lui. Quella sera furono arrestate tante persone. Pioveva, io e mio padre ci riparammo nei pressi di Villa Sciarra. Trovammo ospitalità in un appartamento libero. La mattina scendevamo in strada, facevamo dei piccoli acquisti che, in giornata, rivendevamo a coloro che ne avevano necessità.
Il 7 aprile del 1944 fu l’ultima volta che vidi la mia famiglia. Stavamo festeggiando la Pesach, la Pasqua ebraica, e per noi è molto importante. Quella sera eravamo riuniti intorno alla tavola, non avevamo ancora iniziato la cena. Entrarono in casa due S.S. ed un italiano fascista. In venti minuti dovevamo essere fuori, portare con noi abiti e le nostre ricchezze che, a detta loro, ce li avrebbero riconsegnati. Erano degli sciacalli. Fummo portati nel carcere di Regina Coeli, senza avere alcuna colpa.
Mio padre ebbe la percezione di quello che stava accadendo e disse “Siate uomini, non perdete mai la dignità.” All’interno del carcere trovammo solidarietà da parte degli altri detenuti; cercarono di farsi da parte e lasciare un posto per noi per farci riposare tranquilli. Arrivarono dei camion e fummo trasportati a nord di Roma, a Prima Porta. Il giorno dopo arrivammo nel Campo di Concentramento di Fossoli, nella campagna di Carpi in Emilia Romagna.
Il 16 maggio ci portarono alla stazione dove salimmo a bordo di un treno merci, stipati come bestiame sotto il sole cocente e senza più acqua per dissetarci. Il treno impiegò una nottata per fare circa 100 chilometri ed arrivare a Verona. Il giorno seguente proseguimmo il viaggio fino vicino a Bolzano. Viaggiammo in quelle condizioni 5 giorni e 4 notti. Il 23 maggio il treno arrivò nel campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. Mi chiesero l’età e risposi di avere 15 anni, allora mi dissero di dire che avevo 18 anni. Mi tatuarono sul braccio sinistro il numero A5506. All’appello ci chiamavano con i numeri che ci avevano impresso nel corpo. Il lavoro era massacrante, dovevamo scavare dei canali. Mi era stato insegnato un sistema per trovare l’acqua: quando pioveva infilavamo una canna spaccata e sotto mettevamo una ciotola. L’acqua ce la portavano all’ora del pasto insieme ad una minestra calda. Molti non sopravvivevano per la fatica. Quando arrivavano gli ufficiali delle S.S. facevano una selezione, spartivano le persone in due file: a destra anziani, donne e bambini portati nelle camere a gas. A sinistra gli altri, costretti a fare lavori massacranti, ad assistere alle torture e alla morte. Fu difficile. Oggi coloro che hanno sterminato oltre sei milioni di persone non ci sono più, i loro nipoti non possono avere colpe”.

Al termine dell’incontro i detenuti hanno consegnato omaggi all’ospite Piero Terracina.
Foto di Manola Solfanelli